In ricordo di Gregg Allman [1947-2017]
Nel terzo dei quattro racconti di Richard Ford riuniti nel volume Tutto Potrebbe Andare Molto Peggio (Let Me Be Frank With You, 2014; da noi l’anno dopo, per Feltrinelli, nell’ottima traduzione di Vincenzo Mantovani), Frank Bascombe — il personaggio dell’uomo «qualunque» cui l’autore deve la propria notorietà in ambito letterario — si rivolge all’altra protagonista dell’episodio, la signora Pines, provata da una consistente serie di lutti, dicendole, «Siamo i new normal», non borghesi né distaccati, solo persone abituate a considerare la vita come una successione di circostanze ordinarie.
Nessuno avrebbe invece mai potuto considerare Gregg LeNoir Allman, nato nel dicembre del 1947 a Nashville, in Tennessee, e morto lo scorso 27 maggio, per il peggioramento di un cancro al fegato, nella sua casa di Richmond Hill, in Georgia, un individuo normale, «old» o «new» che fosse, perché nella sua biografia personale, familiare e musicale i fatti eccezionali si erano riproposti con estrema frequenza. Quando il nostro aveva appena due anni, infatti, il padre — sergente dell’esercito da poco promosso al grado di capitano — era stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un tale Buddy Green, autostoppista cui aveva offerto un passaggio in macchina di ritorno dal bar, e in ragione delle crescenti difficoltà sperimentate dalla madre Geraldine nel conciliare educazione dei figli e lavoro, Gregg e il fratello maggiore, Duane, erano stati affidati all’Accademia Militare di Castle Heights, dove il minore, sentendosi rifiutato dalla genitrice e isolato dal resto della società, aveva conosciuto momenti di profonda solitudine.
La famiglia si riunì nel 1959, in occasione di un ennesimo trasferimento a Daytona Beach, in Florida, nei cui dintorni Gregg e Duane sfogarono un’adolescenza ribelle e indisciplinata, poco propensa a sottoporsi al rigore della scuola e altresì assai incline a inseguire ragazze e musica. Quest’ultima si era introdotta nel piccolo mondo dei fratelli sotto forma di una chitarra Silvertone, acquistata da Gregg con i soldi guadagnati consegnando quotidiani a domicilio, sul cui uso avrebbero spesso litigato finché, nella seconda metà dei Sessanta, allorché i due già si esibivano nelle regioni confinanti con il nome di Allman Joys, l’incontro con un tastiera Vox non avrebbe convinto il più piccolo a cambiare strumento.
Intossicata dal blues e dalle droghe, la Allman Brothers Band, con i fluviali dialoghi tra le sei corde di Duane Allman e Richard “Dickey” Betts, l’intercalare fra le tastiere di Gregg e il basso melodico di Berry Oakley (senza dimenticare la doppia batteria martellante e jazzata di Claude Hudson “Butch” Trucks, suicidatosi con un colpo di pistola alla testa lo scorso 17 gennaio, all’età di 69 anni, e del percussionista nero Johnny Lee Johnson, detto “Jaimoe”), divenne non solo uno dei più grandi gruppi rock del pianeta ma l’emblema stesso del rock cosiddetto “sudista”, ossia un intreccio muscolare di country e blues mandato in orbita da improvvisazioni collettive, furiose e selvagge, e di conseguenza il modello di riferimento per il suono di chiunque, nel successivo mezzo secolo, abbia voluto fregiarsi del titolo di jam-band.
In mezzo a fiumi di alcol e secchiate di eroina e cocaina, per non parlare di erba e acidi, gli Allmans si ritrovarono orfani di uno dei loro motori creativi, e Gregg di un fratello, quando nel 1971, all’apice del successo, Duane perse la vita in un incidente stradale; al tragico evento si sommò, solamente un anno dopo, la scomparsa altrettanto accidentale di Oakley, anche lui deceduto, in circostanze quasi analoghe a quelle di Duane, in sella alla propria motocicletta. Il gruppo, ormai capitanato da Betts, decise di non sciogliersi, opzione che venne presa in considerazione solo quando i suoi dischi, a detta dei loro stessi artefici, iniziarono a farsi «imbarazzanti». Si aprivano allora gli anni ’80, decennio in cui Gregg, già sufficientemente irrequieto da aver formato, qualche stagione prima, la Gregg Allman Band (riscuotendo peraltro un lusinghiero consenso di pubblico) e da aver consumato ben tre matrimoni, uno dei quali (molto chiacchierato e molto pacchiano, nonché foriero di un avvilente disco a quattro mani), con l’attrice e cantante Cher, avrebbe dichiarato (nell’autobiografia My Cross To Bear, uscita nel 2012) d’aver sofferto di spaventosi vuoti di memoria causati da un consumo sfrenato di alcolici. Nonostante il successo degli album solisti, Allman continuò a bere e a fare uso di droghe in modo pressoché compulsivo, arrivando persino a procurarsi un’overdose nei primi giorni dell’(ennesimo) matrimonio (con Danielle Galliano, sei anni di unione fino al 1994) e cercando inutilmente , nel frattempo, di riconciliarsi con i figli avuti dalle precedenti relazioni.
Riuniti gli Allmans, per la gioia di critica e ascoltatori, Gregg era rimasto con loro fino al 2014 degli ultimi concerti, attraversando indenne la disintossicazione da liquori e stupefacenti, i dissapori con Betts e la morte prematura del bassista Allen Woody, e facendosi mèntore finalmente saggio, affidabile e maturo di nuovi talenti quali i fulminanti chitarristi Warren Haynes (nel gruppo dal 1989 al 1997, poi dal 2000 al 2014) e Derek Trucks (dal 1999 al 2014), il percussionista latino Marc Quiñones (dal 1991 al 2014) o il bassista di colore Oteil Burbridge (dal 1997 al 2014).
Nel 2011, la stupenda aristocrazia tradizionalista dell’elegante Low Country Blues, prodotto da T-Bone Burnett, lo aveva riportato ai vertici anche in senso discografico giocando sull’antica ricchezza del suono delle radici e mostrando un artista ormai talmente equilibrato da esibire una signorilità délabrée, composta in egual misura da ricercatezza e modestia, estranea agli strilli grossolani del portamento contemporaneo. Il nuovo Southern Blood, affidato alle cure di Don Was, sarebbe dovuto uscire all’inizio di quest’anno, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute del nostro, dal 2007 in lotta contro un’epatite C secondo lui contratta dall’ago non sanificato di un tatuatore e inoltre affaticato da tre tumori al fegato e continue infezioni alle vie respiratorie, ne ha posticipato la pubblicazione a data ancora da stabilirsi.
Qualunque possa essere il contenuto del disco, basterebbero la solennità al rallentatore di It’s Not My Cross To Bear (1969), l’incanto jazz, alla Miles Davis, della suggestiva Dreams (1969), l’intensità rockista e malinconica di Please Call Home (1970), la delicatezza elettroacustica di Melissa (1972), i ruggiti di Wasted Words (1974) o la dichiarazione d’indipendenza e personalità della struggente, trascinante Midnight Rider (1970) a farci ricordare Gregg Allman come l’uomo bianco che seppe cantare e domare il blues in modo forse non sempre lucido (anzi, talvolta eccessivo), ma senza mai rinunciare alla passione e allo slancio dei grandi.
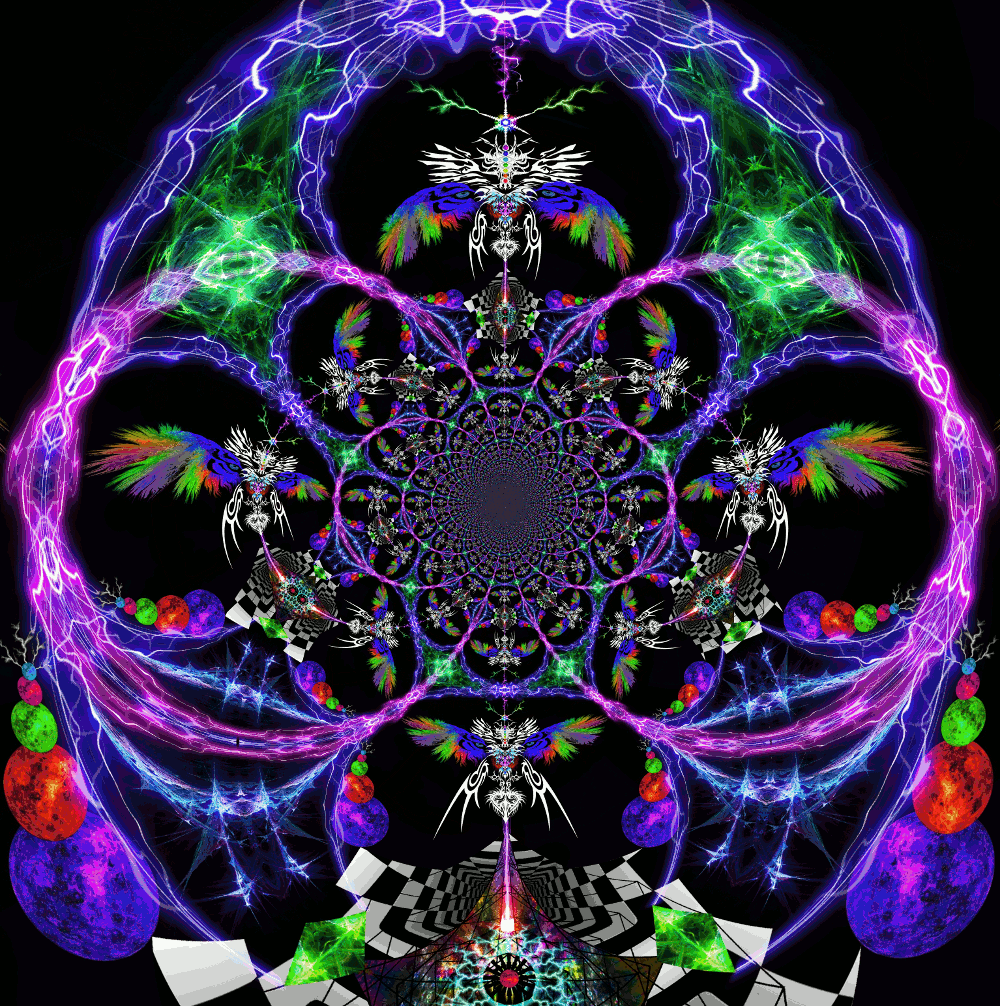










Nessun commento:
Posta un commento